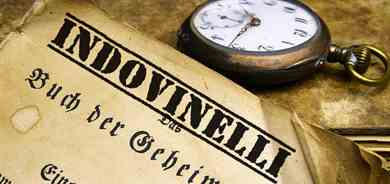inserito da Santino, 30/01/2017 22:49:05
Introduzione
Perché è stato scelto il tema “la famiglia” .
Quando ci siamo incontrate per scegliere uno tra i tanti temi proposti per questo lavoro, ci è stato quasi spontaneo trattare quello sulla famiglia, in quanto abbiamo ritenuto che fosse un “elemento” comune a tutte noi: ci conosciamo da diverso tempo e sappiamo che ognuna di noi vive ancora nel nucleo familiare originario.
Discutendo, ci siamo rese conto che la famiglia, se è lecito usare una metafora, rappresenta per noi il tronco di un grande albero, pieno di rami, i quali simboleggiano la totalità della nostra vita: le amicizie, le scelte, l’amore, i valori morali.
Era, quindi, condiviso il fatto che proprio la famiglia costituisse il fulcro continuo nello sviluppo biologico, psicologico, e sociale di ogni persona, dall’infanzia alla vita adulta.
Proprio per questo abbiamo cercato di analizzare come il vissuto familiare ha, in qualche modo, influenzato le nostre relazioni interpersonali, passate e presenti, e come potrebbe incidere su quelle future.
L’ adolescenza è il periodo in cui il giovane si distacca dalla famiglia, per formare una sua identità. Tuttavia non è possibile generalizzare ciò che avviene nelle famiglie, perché queste si diversificano per il tempo storico, caratteristiche dei componenti, la personalità, la storia di ogni membro, ecc..
La famiglia tipica dell’era moderna, è composta dai genitori e da 1 o 2 figli; questo nucleo così composto è un risultato del processo di industrializzazione, che ha segnato la fine della famiglia patriarcale, e ha dato inizio alla diade madre-figlio. Questa relazione, oggi tanto prolungata tra due individui che vivono in comune la quotidianità, crea legami capaci di influenzare la persona per tutta l’esistenza. Nel periodo preindustriale il giovane cominciava a lavorare prima dei 10 anni, andando a vivere in un’altra famiglia e acquisendo così uno status di semi-libertà; oggi, invece, l’adolescente continua a studiare rimanendo in uno stato di prolungata dipendenza dalla famiglia, anche fino all’età adulta.
E’, quindi, uno dei principali obiettivi dell’adolescente “moderno” riuscire ad emanciparsi dalla famiglia.
EMANCIPAZIONE DALLA FAMIGLIA
Il raggiungimento di indipendenza del giovane, avviene attraverso una ristrutturazione della personalità, basata sulle proprie capacità di “cavarsela da solo” ! In alcuni casi, però questa emancipazione non è ben vista, ed addirittura ostacolata dal genitore che non accetta che il “suo bambino” stia crescendo. Nascono quindi restrizioni alla libertà, vissute dall’adolescente con ansia e sensi di colpa, visto che non riesce a ribellarsi allo stato di subordinazione al quale è sottoposto attraverso l’imposizione di ordini senza spiegazioni, ricatti morali, mezzi fisici ecc.. In altri casi, questa emancipazione avviene in modo tranquillo e senza tanti problemi, preceduta da periodi in cui i bambini vengono incoraggiati ad essere responsabili secondo le loro capacità. Così il giovane adolescente passa da una desatellizzazione dai genitori, verso una satellizzazione attorno ai gruppi di coetanei, il che porta alla realizzazione di legami emozionali di dipendenza meno profondi di quelli stabiliti con i genitori. Il processo di emancipazione è complicato e difficile per l’adolescente che insegue la propria autonomia, ma che, allo stesso tempo necessita della famiglia sorgente di protezione ed aiuto. Ed è proprio in famiglia che l’adolescente viene a contatto con quelle norme di convivenza, che se rispettate e decise da tutti sono un valido supporto per la maturazione dei valori morali e del rispetto per gli altri.
COME AVVIENE L’EMANCIPAZIONE
Per Ausubel, “desatellizzazione” indica il concetto di emancipazione, perché essa è la fase che prepara la maturità dell’io adulto, sulla quale incidono, per ritardarla o accelerarla, il comportamento dei genitori, la personalità del giovane e la cultura in cui questo è inserito .
L’allontanamento dalla famiglia può avvenire, per esempio, per una gita, per un viaggio di studio, una vacanza, o attraverso bugie. Non di rado, lo scostamento è realizzato utilizzando anche il cibo: assunzione di diete particolari, digiuno, anoressia mentale. L’adolescente si distacca rifiutandosi di corrispondere le ambizioni dei genitori, e di spingendosi, come dice Erikson, verso l’assunzione di identità negative.
INCOMUNICABILITA’ E CONFLITTI TRA GENITORI E FIGLI
Nascono da una mancata instaurazione di dialogo “autentico”, cioè intimo, tra le due parti. I conflitti non vengono quasi mai riconosciuti consciamente, perché provocherebbero insicurezza, sensi di colpa o sarebbero vissuti con ansia. Spesso la nascita dei conflitti è legata delle difficoltà nelle relazioni tra i membri della famiglia oppure alla ribellione dell’adolescente che ricerca la propria indipendenza.
LA VIOLENZA
La famiglia per Gelles e Straus, è “il gruppo sociale più violento dopo la polizia e l’esercito”; infatti dalle ultime indagini sui maltrattamenti che gli adolescenti e i bambini subiscono, risulta che gli abusi denunciati negli Stati Uniti sono circa 50.000 all’anno. Il più delle volte l’uso della violenza all’interno della famiglia è il mezzo per reprimere la voglia di autonomia dell’adolescente. Le conseguenze che questo comporta sono molteplici: l’adolescente prova odio mescolato ad amore per quel genitore che si rende artefice della violenza e si sentirà, a sua volta rifiutato sforzandosi di trovare una ragione ai maltrattamenti subiti. La crisi, il senso di colpa e di ansietà, potrebbero provocare anche l’identificazione con l’aggressore, impedendo così di instaurare rapporti non paritari con gli altri.
LA CRISI DEI GENITORI
In alcuni casi i genitori vivono le crisi dei figli in modo speculare, cioè attivando il proprio passato di adolescenti. Varie ipotesi si propongono di spiegare l’ostilità dei genitori verso gli adolescenti che cercano di emanciparsi. Tra le ragioni principali c’è la presa di coscienza di non essere più indispensabili per i figli; il non voler che il “debole figlio” affronti tutto da solo; Pearson vede nei conflitti lo scontro tra due narcisismi, così il figlio diventa l’estensione del sé per il genitore, e deve realizzare le sue aspettative. Il genitore entra in crisi anche perché prova, in modo più o meno inconscio, gelosia per la vitalità, la bellezza e la gioia del figlio.
IL RUOLO DEL PADRE E DELLA MADRE
E’ la madre ad educare i figli nella gran parte dei casi, ed è spesso con lei che nascono il maggior numero dei conflitti adolescenziali. Il padre è la figura più autoritaria dei due, con cui è difficile confidarsi e così molto spesso la madre diventa una complice per i figli..........
I RAGAZZI E LE RAGAZZE
Le differenze tra i due sessi si evidenziano ancora di più durante l’adolescenza, quando per le ragazze inizia una serie di “ restrizioni” prima non conosciute; il controllo delle uscite, delle compagnie,......dei ragazzi. Inoltre vengono ancora deputate ai lavori domestici, che toccano, tranne poche eccezioni ,ancora esclusivamente a loro. Sono quindi le ragazze ad avere un maggior numero di problemi in casa, per quanto riguarda l’emancipazione;
LA CULTURA
L’epoca storica e la cultura condizionano i rapporti tra i genitori e i figli. Ad esempio, in Italia, l’industrializzazione del Nord e il trascurato ammodernamento del Sud, hanno avuto molte influenze. Anche se non in tutti i casi è così, possiamo dire che nel Sud è più difficile vivere l’adolescenza, soprattutto fuori dai grandi centri abitati. La tradizione maschilista ancora sopravvive: le ragazze devono rimanere fedeli al loro ruolo di moglie e di madre, i ragazzi a quello di cacciatore e dominatore. Il matrimonio è, per la ragazza il passaggio ad un diverso dominatore: dal padre e dai fratelli al marito. Si emancipano un po’ di più le ragazze che vivono lontano da casa per motivi di studio.
FIGLI LAVORATORI, DISOCCUPATI E STUDENTI .
Qualunque occupazione porta ad una emancipazione dei figli dai genitori. Per ragazzi e ragazze, il lavoro ha una duplice funzione: i figli trovano una certa indipendenza economica e per questo si sentono più “grandi”, più “sicuri” poiché possono disporre come vogliono della loro vita. Spesso capita che sia il desiderio di autonomia, a far si che i giovani lascino gli studi. La disoccupazione genera non pochi conflitti e tensioni in famiglia, però può anche ridurre i contrasti, quando i figli avvertono un certo senso di colpa dovuto al dover “gravare” sui genitori.
Per i genitori, potrebbe essere una “situazione di comodo”, in quanto ritardano l’emancipazione e l’autonomia dei figli, tenendoseli in casa; tale sottomissione può sfociare in atti di vandalismo e aggressività fuori casa. La ragazza che lavora e si realizza nell’occupazione, prende coscienza della sua condizione di donna, e rivendica anche in famiglia il suo ruolo di donna emancipata. I genitori accettano di più la disoccupazione di una figlia che non di un figlio. Gli studenti hanno più strumenti che favoriscono il processo di emancipazione rispetto a chi non ha ricevuto istruzione; è anche vero, che spesso la loro ritardata emancipazione porta
a dei problemi psichici, che ritardano ancora di più la maturazione della personalità.
I FIGLI HANDICAPPATI
Il rapporto tra genitori e figli handicappati è molto difficile; la madre è molto importante durante l’infanzia, spesso ella si sente in colpa per il figlio e diventa iperprotettiva. Anche il figlio può attaccarsi morbosamente alla madre, che rappresenta protezione contro i pericoli esterni. Si creano così sentimenti ambivalenti di odio/amore. Il padre, spesso assente, assume un ruolo marginale per il figlio. Fratelli e sorelle potrebbero essere trascurati in favore del figlio handicappato. L’emancipazione è più difficile: spesso l’handicappato non riesce ad affrontare il mondo esterno, si chiude in se stesso, dipende totalmente dai genitori. L’iperprotettività ritarda la presa di coscienza dell’handicap, e quindi comporta in “isolamento dal sociale”. Quindi per un ragazzo handicappato il periodo dell’adolescenza può durare più a lungo, rispetto ad un ragazzo sano. L’handicappato può reagire a tutto questo stato di cose, con atteggiamenti aggressivi e regressivi. In altri casi il disabile riesce a prendere contatti sociali, favorendo la sua autonomizzazione, riuscendosi ad accettare prima come persona e poi come handicappato.
DIVERSITA’ TRA FAMIGLIA
Ci possono essere situazioni molto diverse nelle varie famiglie. In caso di mancanza di un genitore, il figlio tende ad “idealizzarlo”, inventando con la fantasia situazioni diverse per ricreare la “normalità”. A volte in assenza del padre, è il nonno che assume il ruolo di “pater familias”, diventando la figura a cui ispirarsi durante l’adolescenza. I rapporti con i fratelli possono essere diversissimi (odio, gelosia, rivalità, complicità, ecc.), ma possono cambiare perché si evolvono con l’evolversi della storia della famiglia. La morte di un genitore è un’esperienza traumatica per i figli. Uno dei meccanismi di difesa è la rimozione, per cui un soggetto non parla mai dell’evento spiacevole; così l’evento si sposta alla sfera dell’inconscio, e a lungo andare, può provocare ansietà e turbe varie. Il figlio può isolarsi, pensare al suicidio e Dio ha la colpa di tutto. A volte il figlio assume il ruolo del genitore mancante, o cerca un partner in cui identificarlo. In casi di malattia grave o di abbandono di un genitore, le reazioni sono le stesse che nel caso di morte ( sensi di colpa). Anche la scoperta di una relazione extraconiugale può portare conseguenze profonde nello sviluppo adolescenziale.
LA FAMIGLIA NEI PROGETTI DI VITA DEGLI ADOLESCENTI
Statisticamente i giovani non vogliono riprodurre il loro modello di famiglia. I giovani considerano la famiglia un’istituzione valida, a patto che rispetti le esigenze e favorisca lo sviluppo delle personalità di ogni membro. Una minoranza dei ceti privilegiati o colti, sono favorevoli alla convivenza; molti sono contrari alla coppia aperta. Chi ha avuto buoni rapporti con i genitori è più favorevole alla famiglia. Nel caso di emarginati sociali (tossicodipendenti, handicappati, ecc.), sono oggi numerose le comunità di assistenza, un’alternativa di società in cui si vive in modo diverso; ci sono coppie che accolgono persone emarginate, oppure dei gruppi di famiglia, composti da una decina di persone. Questa alternativa è molto importante, perché segue alcuni principi, come la condivisione con gli emarginati, non violenza, parità, ecc., che sono antagonisti a quelli vigenti nella società attuale.
METODOLOGIA DI RICERCA: IL METODO QUALITATIVO
La ricerca, nella scienza umana è un rapporto tra persone, e tutti i tipi di relazioni umane si riflettono in metodi e psicologie molto diverse tra loro, contrariamente a quanti pensano di poter fondare una psicologia unificata in un sistema scientifico-positivistico, che implica rapporti alienanti di dominio e riduce le persone ad oggetti manipolabili, senza più considerare il loro essere persona (soggettività, creatività, storia, libertà, individualità, ecc.) costringendoli a trasformare tutto ciò in risposte standardizzate e uniformi presenti nei questionari “prefabbricati” o nei test, proprio come prevede quello che si definisce “modello quantitativo”, ispirato alle scienze naturali e matematiche.
Esistono invece, ricerche fondate sui rapporti paritari in cui viene rispettata l’etica di tutti i partecipanti, compreso il ricercatore, e sono queste le uniche che possono addentrarsi nella psiche umana .
Il modello qualitativo concentra la sua attenzione sul singolo e non sul gruppo; la conoscenza di una persona presuppone quella della sua storia, ed è per questo che il metodo clinico è anche metodo storico. E’ importante sottolineare però, quanto la ricerca qualitativa sia esigente e “pericolosa”: il ricercatore non ha più la possibilità di nascondersi dietro strumenti “scientifici” (test, questionari, ecc.) perché è costretto a interagire in un dialogo con l’altro, a svelare anche le sue debolezze, i suoi pregiudizi, i suoi limiti.
Lo scopo di un ricercatore è importante in quanto va ad influenzare tutte le fasi della ricerca, sia che questa si occupi di temi “impegnati” che coinvolgono le persone, la loro creatività, la loro spontaneità, le loro emozioni, sia che si tratti di una ricerca “pura”. La scelta del tema è dettata dallo scopo della ricerca e, quindi anche questi scopi possono essere di elevato numero ( famiglia, amicizia, amore, tempo libero, tossicodipendenza, ecc.) e si devono considerare in una prospettiva evolutiva (tramite strategie di ricerca e ricostruzione di storie di vita).
Affrontando un qualsiasi tema, il modello qualitativo solo raramente utilizza ipotesi, e quando avviene è solo in maniera subordinata.
Le strategie di ricerca utilizzate per raccogliere le storie di vita sono numerose e tra queste vi sono quelle trasversali, longitudinali, sequenziali e biografiche. Le ricerche trasversali sono utilizzate soprattutto in psicologia evolutiva ed esaminano vari gruppi di individui, divisi in fasce di età diversa, nello stesso tempo. Questo tipo di strategia è economica e permette la formazione di gruppi omogenei o simili, però non permette di conoscere cosa sono dovute le differenze tra i vari gruppi, se all’età oppure all’evoluzione storica.
Le strategie longitudinali sono quelle dove gli stessi soggetti vengono studiati ripetutamente per vari mesi o anni. Queste colgono le traiettorie individuali dello sviluppo, però sono costose e poco flessibili, perché non permettono la distinzione tra effetti dovuti all’età e influenze del periodo storico.
Le strategie sequenziali, sono una combinazione delle due strategie precedenti, per rimediare agli inconvenienti da queste posseduti.
Le strategie biografiche vengono usate per capire l’individuo attraverso la sua storia di vita; lo scopo è la comprensione dell’individuo e non di gruppi di persone o di un’intera popolazione.
Tra le tecniche di raccolta dei dati di cui il modello storico-clinico fa maggiormente uso vi sono il colloquio, le discussioni di gruppo, la composizione scritta e l’osservazione; il ricercatore può anche amplificare le notizie raccolte servendosi di disegni, diari, riflessioni ricordi consci e inconsci, informazioni sull’ambiente in cui il soggetto esaminato vive.
Il modello qualitativo dovendo ricostruire la storia di vita dell’individuo, predilige la tecnica del dialogo poiché questo lascia al soggetto la più completa libertà di espressione e nello stesso tempo permette al ricercatore di cogliere la globalità della persona, indagando sulla sua soggettività, sulla sua filosofia di vita, sul senso comune dell’esperienza quotidiana.
Dobbiamo però ricordare che l’osservazione non è oggettiva ma soggettiva; nel dialogo la persona si rivela, scopre le sue debolezze e si arriva a comprenderla tramite un rapporto empatico, ovvero la capacità del ricercatore di cogliere le profonde sfumature dell'inconscio.
Concludiamo dicendo che comunque la ricerca sperimentale non è estranea alla psicologia, ma ha sicuramente un posto subordinato rispetto al modello qualitativo, il più adatto allo studio della complessità dell’essere umano.




 Un commento o una richiesta?
Un commento o una richiesta?